
Una delle peculiarità del pensiero di Socrate che in seguito verrà elaborata da Platone è data dal dialogo, inteso come strumento conoscitivo in grado di costruire una verità attraverso lo scambio di opinioni con più interlocutori. In tal modo l'identificazione della verità non avviene più tramite la scoperta di un qualcosa ontologicamente fondato, ma per mezzo di una metodologia che assume i tratti di una gnoseologia che mira alla determinazione di un criterio interpersonale del sapere. Alla base di tale pratica conoscitiva Socrate pone l'ignoranza, ovvero la consapevolezza dei propri limiti, del "sapere di non sapere". Il primo momento del dialogo socratico viene detto protrettico ed ha lo scopo di minare le certezze dell'interlocutore attraverso un uso mirato dell'ironia, della dissimulazione e dell'ostentazione di un'apparente ingenuità. Il secondo momento è dato dall'imbarazzo a cui perviene l'interlocutore quando scopre le conseguenze dalla tesi che ha scelto di sostenere. Una volta avvenuto ciò, l'interlocutore sarà costretto a sviluppare delle teorie personali: proprio per questo Socrate definirà tale tecnica maieutica, poichè causa della nascita di nuove idee. Una delle costanti presenti nel dialogo socratico è data dalla domanda: "che cos'è?". Una tale richiesta rende possibile la determinazione di ciò che Aristotele chiamerà l'essenza delle cose, o anche il loro concetto: da un certo numero di singoli uomini, ad esempio, si può arrivare a stabilire interpersonalmente che cos'è l'uomo. Altro punto fondamentale del pensiero socratico sta nell'identificazione tra sapere e virtù, da cui discende la convinzione dell'insegnabilità della virtù. Quest'ultima, infatti, può essere definita come una scienza del bene e del male, ed ha la stessa possibilità di essere insegnata di qualunque altra disciplina: nel momento in cui si conosce la differenza tra bene e male, è impossibile agire non in conformità con la virtù. Tale affermazione sta alla base dell'intellettualismo etico di Socrate, in quanto sottende il primato della conoscenza sulla volontà, eludendo qualsiasi componente emotiva. Dal concetto socratico del bene traspare una concezione interiorizzata dell'uomo, le cui peculiarità risultano orientate verso la sua anima, considerata come la vera realtà umana, nei confronti della quale il corpo svolge una mera funzione strumentale. Il motto "conosci te stesso", quindi, viene da Socrate inteso come un'esortazione a riconoscere nell'anima la vera realtà dell'uomo e nella virtù il suo compimento.
Riflessione: "Il diletto è dalla parte di quelli che sanno a metà". F.W. Nietzsche
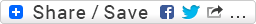


































.jpg)
































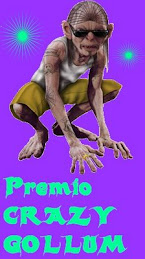
9 commenti:
Ciao caro, sono passata per augurarti buon week end!
Baci
Peppe complimenti per il post. Da perfetto ignorante, quale sono, lo dovrò rileggere almeno 5 volte per trovarne l'essenza ma, tu che l'hai proposto meriti questi apprezzamnti:-)
Buona giornata
Niente da fare, la filosofia proprio non è per me.
la tua è stata una missione epica... ma ci sei riuscito alla perfezione....
sei eccezionale Peppe...
le lasagne erano buone...
;-)
buon appetito
cosa posso dirti sei eccezionale per me che la filosofia non è il mio forte dico bravo caro peppe.
Un caloroso saluto,
Tomaso
io so che niente so bella^^...
un bacionee carooooo peppe^^
Socrate aveva perfettamente ragione ;)
Peppe su quello che mi hai scritto nel mio post, ti invito a creare un molti gruppi spontanei di cittadini per sorvegliare attentamente i vostri amici politici. Sono sicuro che scoprirete delle cose interessanti ;)
Un grande saluto da Raimondo
carissimo peppe ne titolo del post c'e' tutto ...io so di non saper pero' una cosa so che sei un nostro grande amico blogdiano
crazie amico mio
la frase che fu detta da Socrate ,è una frase molto profonda.
una frase puo' contenere poche parole,ma avere un significato molto grande.
tutti dovremmo ammettere di non sapere ,anche quando si sa'.
c'è sempre qualcosa che noi non conosciamo.
ciao Peppe(sto cominciando ora a conoscerti,a te e agli altri blogger,siete una nuova famiglia mai vissuta)
Posta un commento